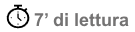
Lo scorso 16 gennaio la Camera dei deputati ha approvato, in prima deliberazione, il testo del disegno di legge costituzionale, di iniziativa governativa, noto alle cronache come “riforma della separazione delle carriere”.
Invero, l’articolato si impernia su tre pilastri: la separazione delle carriere, appunto, di giudici e pubblici ministeri con la creazione di due distinti CSM, entrambi presieduti dal Presidente della Repubblica; la selezione mediante sorteggio dei componenti dei due nuovi Consigli; l’attribuzione a una nuova «Alta Corte», composta da magistrati, professori universitari e avvocati, anch’essi selezionati mediante sorteggio, della «giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari».
L’articolato è transitato verso Palazzo Madama esattamente com’era entrato a Montecitorio, non solo senza che si sia registrata alcuna modifica rispetto al testo uscito da Palazzo Chigi ma senza neppure alcuna reale discussione. Dunque, un progetto governativo formalmente e sostanzialmente blindato, che non ha lasciato alcuno spazio per il dibattito e le scelte nella sede propria, segno tangibile del più grave dei mali istituzionali della Repubblica, la completa neutralizzazione di fatto del Parlamento, persino nell’espletamento del suo compito più significativo, la riforma della Costituzione.
Peccato, perché di materiale su cui discutere, come si coglie agevolmente, ce ne sarebbe a iosa e, va riconosciuto, al netto dei processi alle intenzioni, non fatto di sole ombre; perché, inoltre, il disegno governativo si presenta assai grezzo e bisognevole di quel modellamento che non solo spetterebbe formalmente al Parlamento ma che solo dal Parlamento e in Parlamento potrebbe essere adeguatamente compiuto.
Invece, tutto è già impostato in modalità puramente elettorale. E anche stavolta ci si dovrà rassegnare all’ormai consueto prendere o lasciare.
Sarebbe auspicabile che, almeno in vista del referendum, il dibattito si concentrasse adeguatamente sul merito delle più importanti questioni poste dagli snodi principali della riforma.
Qui è possibile solo farvi cenno fugacemente.
È innegabile che, di per sé, la separazione delle carriere, presente nella stragrande maggioranza delle cosiddette democrazie liberali, non condurrebbe il Paese fuori dal perimetro dello stato di diritto. Come pure bisognerebbe prendere atto che il progetto riformatore neutralizza il principale argomento dei detrattori della separazione, ossia l’assoggettamento del pubblico ministero all’esecutivo e il connesso abbandono del principio di obbligatorietà dell’azione penale. Nondimeno, il pionieristico disegno di riforma, unico caso al mondo di convivenza di due ordini giudiziari separati e autonomi, quello della decisione e quello dell’azione pubblica (non si dica che c’è già il Portogallo perché il caso lusitano è un chiaro esempio di sottoposizione del pubblico ministero all’esecutivo: il Procuratore Generale, gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato agli altri procuratori, è nominato dal Ministro della Giustizia), non manca di destare perplessità. Appare altissimo il rischio di eterogenesi del dichiarato fine di rafforzare la posizione di terzietà del giudice, rendendolo meno permeabile alle ragioni del “collega” pubblico ministero. Infatti, separato dal giudice ma parimenti autonomo e indipendente, il pubblico ministero sarà probabilmente ancora più forte. Sciolto dalla minoritaria comunanza ordinamentale col giudice, nella quale oggi sono assorbite e normalmente dissolte senza traumi istituzionali le tensioni del potenziale contrasto tra funzione requirente e funzione giudicante, ma dotato della stessa legittimazione formale, avente la sua fonte nella legge, il pubblico ministero diventerà centro esclusivo di polarizzazione delle esigenze di difesa sociale, inevitabilmente prorompenti rispetto ai diritti di libertà e garanzia individuale, e delle istanze punitive degli apparati di polizia, e assumerà di fatto una forza politica la cui pressione si scaricherà costantemente sul giudice, il quale, soprattutto nei momenti topici, quelli su cui si misura la reale adeguatezza di un sistema, dovrà fare i conti col rischio di essere percepito come ostacolo al dispiegarsi della opportuna e necessaria attività di contrasto al crimine. Molto critica, in questo contesto, la posizione bifronte del Presidente della Repubblica, chiamato a presiedere i due distinti consigli superiori, potenzialmente in costante contrasto tra loro.
Il secondo pilastro della riforma, ossia l’opzione randomica per la composizione degli organi di autogoverno, rappresenta il dato di vera svolta e, al contempo, il nodo sicuramente più avversato dalle correnti dell’ANM. E non è difficile capire perché. Esso porrebbe fine al potere correntizio di sistematica programmazione della composizione del CSM con tutto ciò che, a cascata, ne discende, valorizzerebbe il ruolo e la dignità dei singoli magistrati, riconoscendone la legittimazione alla piena e diretta partecipazione al c.d. “circuito dell’autogoverno” senza sottostare al giogo dei capicorrente e depurerebbe finalmente lo stesso autogoverno dall’oligarchico e distorsivo condizionamento dei partiti (togati e non). Nondimeno, la previsione riformatrice si presenta eccessivamente lacunosa, omettendo tra l’altro di vincolare la necessaria legge attuativa al criterio della rappresentatività delle diverse categorie di magistrati che dovrebbe costituire tratto essenziale di ogni organo di autogoverno. Paradossalmente, nel sistema riformato, i CSM dei giudici e dei pubblici ministeri potrebbero essere riservati, rispettivamente, ai soli componenti della Corte di cassazione e della Procura generale.
Infine, l’introduzione dell’Alta Corte disciplinare muove dalla convinzione, invero assai discutibile, che la “giustizia domestica” finora esercitata dal CSM sia stata troppo tenera nei riguardi dei magistrati. Peccato che la funzione disciplinare abbia natura essenzialmente domestica. Come per qualsiasi dipendente privato è esercitata dal datore di lavoro, per qualsiasi dipendente pubblico dall’amministrazione di appartenenza e per qualsiasi professionista dal rispettivo ordine professionale, è assolutamente naturale e, vien da dire, necessario, salva a snaturarla completamente, che la funzione disciplinare sia esercitata, nei riguardi dei magistrati, dai rispettivi organi di autogoverno. Trasferire all’esterno l’amministrazione della disciplina degli appartenenti a un corpo di lavoratori significa realizzare un etero-gestione dello stesso corpo, cosa che, innaturale e inopportuna per tutti i lavoratori, per i magistrati stride irrimediabilmente con le garanzie costituzionalmente riconosciute di autonomia e indipendenza dell’ordine. Il vero problema dell’attuale sistema disciplinare non sta nel suo naturale e giusto carattere domestico ma nel fatto che il legislatore ordinario, tradendo smaccatamente il disegno costituzionale e la natura essenzialmente gestionale della funzione disciplinare, con il poco meditato avallo della Corte costituzionale, gli abbia attribuito una innaturale struttura giurisdizionale, forgiando a mo’ di giudice la Sezione disciplinare del CSM e in tal modo non solo violando il divieto di istituire giudici speciali previsto dall’art. 102, 2° comma, della Costituzione ma altresì contraddicendo il carattere diffuso che la Carta costituzionale delinea quale contrassegno distintivo della funzione giurisdizionale (per non dire della connessa sovra-ordinazione a tutti gli altri magistrati del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, affidatario dell’azione disciplinare, in violazione del fondamentale principio di non distinzione dei magistrati se non per diversità di funzione). Se così è, a ben vedere, l’istituenda Alta Corte rappresenta l’inopinato consolidamento dell’attuale assetto, rispetto al quale il sistema partitico-correntizio non solo non ha voluto assumere una posizione critica ma che dalle critiche che in pochi hanno osato rivolgergli lo ha sempre difeso, anche con una certa presunzione. Si comprende bene, allora, che quelle che le correnti associate stanno versando sono solo lacrime di coccodrillo e che la vera ragione di doglianza dell’ANM, anche in relazione all’Alta Corte, è la scelta di non affidare alle correnti il potere di scegliere i componenti dell’organo, dei quali è invece previsto il sorteggio.
Se quelli appena indicati sono solo alcuni dei tanti profili della progettata riforma che, vieppiù considerato l’esautoramento del Parlamento, meriterebbero considerazione e approfondimento nel dibattito pubblico, quest’ultimo, tuttavia, lungi dall’essere un franco e leale confronto nel merito, si presenta viziato dal pregiudizio, condizionato dalle strategie partitiche e, in definitiva, orientato in tutt’altra direzione.
Ne costituisce cartina di tornasole il ripetuto botta e risposta sulla posizione di Giovanni Falcone. I fan della riforma, come prova provata della bontà della stessa, sbandierano il pensiero del magistrato assassinato a Capaci, indubbiamente aperto alla separazione delle carriere, senza tuttavia compiere un minimo di contestualizzazione; i detrattori, pur di non darla vinta agli avversari sulla posizione di Falcone, dissimulano il pensiero del simbolo della buona magistratura fino a privarlo completamente di consistenza. E giù tutti a tirare per la giacchetta chi oggi non può più parlare: per fargli dire più di quanto ha detto o, al contrario, per annebbiare quanto ha senz’altro affermato.
Come se, peraltro, l’essere stato Falcone favorevole o contrario alla separazione delle carriere fosse decisivo a prescindere da un’attuale valutazione delle ragioni che militano in un senso o nell’altro.
Per carità, Giovanni Falcone è stato un eroe civile che ha esercitato la propria professione con capacità e abnegazione non comuni e a volte inarrivabili nonché un intellettuale visionario e anticipatore che ha saputo scorgere questioni e offrire soluzioni con l’impronta che solo ai geni può essere riconosciuta.
Non per questo, tuttavia, il Falcone-pensiero – ammesso e non concesso che possa essere compiutamente ricostruito e che possa acriticamente adattarsi ai tempi attuali – può essere assunto a indiscutibile criterio discriminante di ciò che è esatto o non lo è, di ciò che deve o non deve essere fatto. Peraltro, volendo dare ragione a Falcone, in ipotesi pro-separazione, si farebbe torto a Borsellino, anch’egli magistrato-eroe ma radicalmente contrario alla soluzione separatista.
Se nei prossimi mesi non si registrerà un cambio di rotta, il rischio più grave sarà quello di trasformare il referendum da meditata e consapevole scelta sul merito della riforma in un plebiscito pro o contro il Governo in carica e chi lo guida.
Su tutti, principalmente sulla politica, sulla magistratura e sui media incombe il dovere di evitare che questo accada. Ne varrà non solo per far sì che il momento elettorale risponda compiutamente alla sua funzione ma altresì per orientare le scelte che, quale che ne sarà l’esito, dovranno essere assunte all’indomani del referendum.
