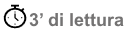
Non c’è dubbio che la notizia che a novembre il nostro debito pubblico abbia sforato, per la prima volta in assoluto, i 3.000 mld di Euro non sia tra le più rassicuranti degli ultimi periodi. E questo perché, da una parte, il costo degli interessi sul debito (in Italia oltre 80 mld l’anno) sottrae disponibilità liquide che potrebbero essere destinate più proficuamente agli investimenti produttivi, alle infrastrutture, alla sanità. Dall’altra, un debito pubblico a questi livelli rende comunque il paese indebitato più vulnerabile ad improvvisi shock esogeni.
Tuttavia, per comprendere effettivamente la pericolosità del nostro debito, non bisogna fermarsi alle sue dimensioni in termini assoluti, ma bisogna esaminare altri tre fattori che influiscono sulla sua sostenibilità nel tempo.
Il primo fattore da considerare è connesso alla crescita del Paese, tanto è vero che, parlando di debito pubblico, si guarda sempre al rapporto DEBITO/PIL. E, sotto questo aspetto, la situazione italiana appare in chiaroscuro. Infatti, non solo il quarto trimestre 2024 si è chiuso con una crescita zero, ma, secondo molti osservatori istituzionali, il nostro PIL dovrebbe crescere quest’anno intorno allo 0,6/0,7%, ben al di sotto delle previsioni del Governo che ha ipotizzato un +1,2%. Dunque, una crescita non certo eclatante. Tuttavia, è importante evidenziare che, in questo scenario, l’Italia può contare, in misura maggiore rispetto agli altri partner europei, sulla carta del PNRR che, secondo un recente studio della BCE, potrebbe spingere il nostro PIL nel 2026 ad un livello compreso tra l’1,5 e l’1,9%. E, su questo fronte, difficilmente il Governo avrebbe potuto fare di più visto che l’Italia ha già incassato ben sei rate per complessivi 122 mld (il 63% del totale) ed ha già richiesto la settima rata di oltre 18 mld.
Il secondo fattore, essenziale per la sostenibilità del nostro debito, è connesso, invece, alla fiducia degli investitori nel “sistema Italia”. E non si può negare che, attualmente, questa fiducia esista e sia tangibile. Più in particolare, questo inedito stato d’animo deriva essenzialmente da due elementi. Il primo è legato all’attuale stabilità politica che risalta ancor di più se paragonata all’instabilità politica di Francia e Germania. Il secondo elemento è che il ministro Giorgetti non solo ha messo al riparo la manovra economica da tentazioni di “finanza allegra”, ma ha anche presentato alla Commissione un Piano Strutturale di Bilancio imperniato su precisi limiti alla crescita della spesa pubblica e sul rientro dal debito in 7 anni. Un piano che, peraltro, è stato considerato equilibrato ed attuabile dalla Commissione stessa. Da evidenziare, infine, che questo clima di fiducia si è percepito anche nell’ambito della prima emissione di BTP a 10 anni del 2025, che ha attirato l’attenzione di oltre 400 investitori di 35 Paesi che hanno sottoscritto oltre il 30% del totale.
Il terzo fattore, riguarda invece la composizione del nostro debito. Infatti, i nostri titoli pubblici sono detenuti per circa il 70% da soggetti residenti e per il 30% da soggetti esteri. E questo è un fattore di rilievo per la sostenibilità del nostro debito dato che il debito “conservato in casa” tende ad essere più stabile rispetto al debito detenuto da soggetti esteri di massima gestito in ottica più speculativa. Per fare un paragone, il Giappone ha un debito pubblico pari al 260% del proprio PIL ((in Italia questo rapporto è pari al 138%), ma il debito giapponese è comunque considerato sostenibile, proprio perché detenuto al 90% da banche, assicurazioni e famiglie nipponiche. Da notare, oltretutto, che solo il 3% della citata emissione di BTP è stato sottoscritto dagli hedge fund, mentre il resto della quota estera è stata appannaggio degli investitori esteri “pazienti” (meno speculativi) quali banche ed assicurazioni, comunque preziosi a fronte della progressiva riduzione dei programmi di acquisto di titoli da parte della BCE.
Dunque, considerando i descritti fattori di sostenibilità, il nostro debito pubblico sembrerebbe “prezzato male”. E questo è dovuto al fatto che la vischiosità dei giudizi delle società di rating, certamente influenzati dai retaggi del passato, tardano a prendere atto del miglioramento strutturale della nostra economia. Il problema è che questo ritardo non è affatto indolore perché ci obbliga a garantire agli acquirenti dei nostri titoli sovrani rendimenti sproporzionati rispetto alla reale rischiosità del Paese. Il che va benissimo per gli investitori, ma molto meno bene per le casse dello Stato.
